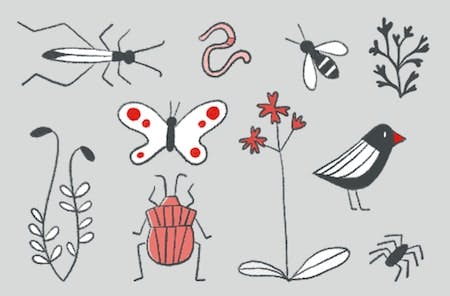magazine_ Interview
"Le montagne sono come isole"
Il biologo Andreas Hilpold sulla biodiversità in alta quota
Oggi, 11 dicembre, è la Giornata internazionale della montagna con focus sulla biodiversità. Perché proprio nelle regioni di montagna questo tema è così importante?
Hilpold: Le montagne sono un hotspot di biodiversità per diversi motivi. Da un lato, i parametri ambientali in montagna cambiano molto rapidamente: in poche centinaia di metri di altitudine flora e fauna sono completamente diverse. Dall’altro, gli ecosistemi montani si comportano quasi come isole. Nei massicci montuosi isolati, si sviluppano continuamente nuove specie che non si trovano in altri luoghi. Ciò che si verifica su larga scala, in montagna può essere scomposto nei minimi dettagli. In avvallamenti e rilievi, in una superficie di un metro quadrato possono esserci delle nicchie microclimatiche con zone soleggiate che registrano una temperatura di 30 gradi e aree in ombra che non superano i 5 gradi.
Da due anni Eurac Research svolge un monitoraggio, per conto della Provincia, sullo stato della biodiversità in Alto Adige. Sembra un progetto enorme se si considera che in Alto Adige vivono circa 2500 specie di piante e almeno dieci volte tanti animali.
Hilpold: Non li stiamo monitorando tutti, ma abbiamo selezionato a priori quali specie ha senso monitorare in quali habitat. Attualmente ci stiamo concentrando su farfalle, cavallette, uccelli, pipistrelli, piante vascolari, muschi...
Perché le farfalle?
Hilpold: Reagiscono in modo molto sensibile ai cambiamenti del clima e dell'uso del suolo, quindi sono un buon indicatore dello stato del loro habitat, che tra l'altro può coprire migliaia di metri quadrati, essendo un insetto volante. Inoltre, le larve spesso vivono in un habitat completamente diverso da quello in cui poi nasceranno le farfalle. Se la pianta di cui si nutrono i bruchi scompare, scompaiono anche le farfalle. In altre parole: dove ci sono le farfalle, il paesaggio deve essere ecologicamente intatto.
Quali specie di uccelli censite?
Hilpold: Osserviamo e documentiamo tutte le specie di uccelli. In un progetto speciale abbiamo anche osservato più da vicino gli uccelli che vivono in prati e pascoli gestiti in modo estensivo. Gli uccelli che nidificano a terra sono ad alto rischio se, ad esempio, la falciatura viene effettuata troppo presto.
Cosa hanno di speciale gli uccelli nelle regioni di montagna?
Hilpold: Si sono adattati molto bene alle condizioni estreme, come la maggior parte delle specie animali e vegetali che vi si trovano. Molte specie come il fringuello alpino, la pernice bianca, il gracchio alpino e il gipeto si trovano solo nelle regioni di montagna. Gli habitat montani non possono essere sostituiti. Le specie non hanno molte opportunità di fuggire da qui.
Il mondo è diventato così complesso che abbiamo bisogno di fatti e di conoscenze empiriche per comprenderlo e prendere decisioni basate sui fatti
Andreas Hilpold
Cosa potrebbe indurli a fuggire?
Hilpold: Al di sopra della linea degli alberi, cioè intorno ai 2200 metri, l'influenza diretta dell'uomo di solito è minima e puntuale. Basta pensare agli impianti di risalita, agli sport d’aria, allo sci alpinismo e alle escursioni. Tuttavia, dopo la rivoluzione industriale, il mondo vive uno stato di sconvolgimento che raggiunge anche gli angoli più remoti della terra. L'uomo interviene in numerosi cicli materiali che portano a un riscaldamento dell'atmosfera. Inoltre, c’è un apporto di azoto e di altre sostanze anche negli ecosistemi montani. In molti casi, le specie sono costrette a cercare nuovi habitat. Inizialmente si muovono in orizzontale, per esempio spostandosi da sud verso il versante nord di una montagna. Ma a un certo punto queste nicchie sono occupate e l'unica opzione che rimane è quella di fuggire verso l'alto.
Cosa succede quando non c'è spazio per salire?
Hilpold: Allora la situazione diventa davvero critica. Sui versanti della Mendola, per esempio, abbiamo trovato l’eufrasia tridentata. Questa specie di fiore non potrà fuggire verso l'alto se il suo habitat attuale dovesse cambiare in modo significativo. Le piante in montagna sono fortemente legate alla loro posizione e solo raramente trovano un habitat sostitutivo. Lo stesso vale per le specie animali che si nutrono di queste piante.
Perché è così importante registrare la biodiversità?
Hilpold: Oltre al cambiamento climatico, il declino della biodiversità sarà uno dei nostri maggiori problemi nei prossimi decenni. Edward Wilson, il guru americano della biodiversità, ha calcolato che se tutti gli insetti e gli artropodi si estinguessero, noi umani li seguiremmo dopo meno di un anno.
Sembra uno scenario drammatico. Gli insetti davvero rischiano un’estinzione di massa?
Hilpold: Nel 2017 è uscito in Germania lo Studio Krehfeld. Mostra che in meno di 30 anni la biomassa degli insetti volanti è diminuita in media del 76,7 per cento. Dagli anni Settanta, gli scienziati hanno raccolto dati sugli insetti volanti in 63 aree in Germania. All'inizio venivano derisi: “A cosa serve quello che fate?”. Oggi sappiamo quanto siano importanti queste indagini a lungo termine. Lo stesso vale probabilmente anche per il monitoraggio della biodiversità in Alto Adige. Alcuni dei nostri studi torneranno utili tra 20-30 anni.
Quindi si tratta di ricerca di base?
Hilpold: Mettiamola così: il mondo è diventato così complesso che abbiamo bisogno di fatti e di conoscenze empiriche per comprenderlo e prendere decisioni basate sui fatti. Quando si tratta di conservazione della natura, non posso contare sul mio istinto. Non sto dicendo che i nostri monitoraggi non possano essere anche di utilità pratica. Ad esempio, possiamo individuare precocemente nuovi parassiti, come il senecio sudafricano che è stato introdotto involontariamente con il commercio della lana di pecora e che ora si trova occasionalmente sui nostri prati e pascoli. Il suo fiore giallo è velenoso per i bovini e i cavalli.
Ci sono state sorprese nei primi due anni di monitoraggio della biodiversità?
Hilpold: Sempre più spesso troviamo specie che non ci saremmo aspettati in certe località, come una piccola specie di muschio nei frutteti vicino a Montagna, o il nibbio reale, un uccello rapace, nei terreni agricoli vicino a Teodone. La scoperta della Grillastro alpino sull'Alpe di Siusi, una specie di cavalletta di cui probabilmente esistono solo dieci popolazioni in tutto il mondo e quasi solo nella regione dolomitica, è stato un evento di assoluto rilievo. Per il resto, molte delle nostre aspettative sono state confermate o addirittura superate, come la biodiversità incredibilmente elevata degli habitat delle zone umide, cioè delle torbiere, dei laghi e delle rive dei fiumi, o la diversità dei pascoli secchi e dei pascoli magri, habitat che sono detentori di record mondiali in termini di diversità vegetale in una piccola area.
Monitoraggio della biodiversità in Alto Adige
Nel 2019 Eurac Research ha avviato, per conto della Provincia autonoma di Bolzano, un progetto di monitoraggio della biodiversità su larga scala. Nell'arco di cinque anni saranno censiti in tutto l'Alto Adige 320 diversi siti appartenenti a 6 grandi categorie di habitat. A fine 2020 sono stati esaminati 128 siti. Le indagini si concentrano su piante vascolari, uccelli, pipistrelli, farfalle, cavallette, muschi e licheni, e vari organismi del suolo. Oltre a flora e fauna vengono registrati anche i parametri del suolo e la struttura del paesaggio. A partire dal 2021, anche i gruppi di animali e piante acquatici saranno censiti per un periodo di quattro anni in 120 siti diversi. Partner del monitoraggio sono il Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige e l'Ufficio Natura della Provincia Autonoma di Bolzano. Il Museo di Scienze Naturali conserva i dati e i campioni prelevati, mentre l'Ufficio Natura è responsabile della raccolta dei dati relativi agli habitat.